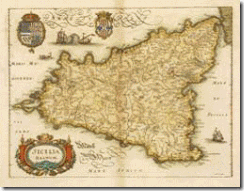IMPRESSIONI DI UN VIAGGIATORE SPAGNOLO DEL ‘500: LA SICILIA
( Gianfranco Romagnoli)
Un manoscritto del 1557, anonimo ma dai più attribuito a Cristóbal de Villalón, un letterato che dopo una vita avventurosa fu professore all’Università di Valladolid, narra, mescolando realtà e invenzione letteraria, un viaggio effettuato in Turchia dal protagonista, che sulla via del ritorno in Spagna attraversò l’Italia passando dalla Sicilia e da Napoli, delle quali diede vive ed interessanti descrizioni.L’opera, edita per la prima volta nel 1905 in Spagna, è strutturata in forma di vivace dialogo tra il viaggiatore qui chiamato Pedro Urdemalas, un nome tratto da una commedia di Cervantes, e due suoi amici dai nomi anch’essi fittizi: Juan de Voto a Dios, da identificarsi, sembra, con Alonso del Portillo, Rettore dell’Università di Alcalá de Henares, e Mátalas Callando, un prete di Granada, i quali gli chiedono notizie e ragguagli sui luoghi visitati.
Per quanto riguarda la Sicilia, il viaggiatore riferisce del suo arrivo «al Faro di Messina dove sono Scilla e Cariddi» e descrive lo Stretto come «un mal passo … un braccio di mare che divide la Sicilia dalla Calabria … pieno di vortici così diabolici che tirano giù le navi», con una caratteristica che lo distingue da ogni altro: e cioè, «che la corrente dell’acqua va da una parte in un verso e dall’altra in un altro … e siccome le correnti sono contrarie l’una all’altra, le navi danno di traverso e si perdono». Della città di Messina non dà alcuna descrizione, perché gli fu impedito di entrarvi a causa della quarantena cui erano sottoposte tutte le navi e così pure i viaggiatori provenienti dall’Oriente: tuttavia, sfuggito ad essa dopo ventotto giorni di permanenza sulla banchina del porto trascorsi tra scomodità, fame e vessazioni di avide autorità, prosegue il suo viaggio per raggiungere Napoli via terra, itinerario preferibile in quanto la rotta marittima era infestata da galere corsare turche che, come venne a sapere, catturarono la nave sulla quale era arrivato in Sicilia. Alle domande dei suoi amici che gli chiedono di un «monte che dicono mandi fuori fiamme di fuoco», risponde: «Questo avviene in Sicilia, in tre o quattro montagne. La principale si chiama Mongibello; è altissima e manda tanto calore che le navi che vi passano vicino sentono l’aria tanto calda da sembrare che siano davanti alla bocca di un forno. E una volta, tra l’altre, ne uscì tanto fuoco che arse tutto intorno per più di sei leghe. Di lì si ricavano quelle pietre fatte come spugne che si chiamano “pomici” e che servono a lisciare il cuoio». Oltre a questa, cita Stromboli e Strombolicchio nonchè, facendo una singolare confusione con il già descritto Mongibello, «un altro vulcano che gli antichi chiamavano Etna, dove dicevano che stavano i ciclopi e i giganti». Di tutti questi vulcani, racconta che «vanno gettando perpetuamente fumo nero e scintille, come se stesse ardendo qualche gran forno di stovigliaio, e la gente dice che quella è la bocca dell’inferno»; precisa inoltre, rispondendo a una domanda dei suoi interlocutori, che nessuno può salire a guardare cosa si veda dentro il cratere «perché appena giunti a mezza strada, cominciano a calpestare terra bruciata simile a cenere! e più avanti vanno, meno facile riesce la salita per il calore che è tanto grande che certamente si brucierebbero». Delle città della Sicilia, parla di Palermo come assai rinomata «e con ragione, perché, sebbene non sia grande, è meglio provveduta di pane e vino e carne e selvaggina e di ogni altro genere di cacciagione che qualunque altra città d’Italia»; cita poi, come belle città, Siracusa, Trapani e Messina (nonostante che quest’ultima, come si è rilevato, vide soltanto il porto, o forse l’attraversò fuggendone nottetempo, ma di questo non ci parla). Dell’incontro di questo viaggiatore con Napoli, parlerò in un prossimo articolo.